 E’ stata recentemente edita dal CEI una Guida riguardante i locali ad uso
medico, per i quali sono entrate in vigore le nuove prescrizioni
introdotte dalla Variante V2 alla Norma CEI 64-8, che ha abrogato la Norma
CEI 64-4.
E’ stata recentemente edita dal CEI una Guida riguardante i locali ad uso
medico, per i quali sono entrate in vigore le nuove prescrizioni
introdotte dalla Variante V2 alla Norma CEI 64-8, che ha abrogato la Norma
CEI 64-4.
Tale variante è stata successivamente inserita integralmente nella Parte
VII della quinta edizione della Norma CEI 64-8/7, nella Sez. 710.
Le novità apportate dalla nuova normativa sono numerose e, tenuto conto
della maggior pericolosità degli impianti elettrici nei locali ad uso
medico, ci si sarebbe aspettati \dalla Guida maggiori e più approfondite
spiegazioni.
Nel seguito si esaminano tali novità, evidenziando gli aspetti che possono
ingenerare dubbi e perplessità.
LE NUOVE PRESCRIZIONI NORMATIVE
E’ opportuno sottolineare, innanzi tutto, che la nuova normativa mantiene
giustamente l’equiparazione dei locali ad uso estetico con quelli ad uso
estetico. Non ci si capacita, invece, della ragione per cui è stata
inserita una frase per i locali ad uso veterinario: “… in quanto
praticamente applicabile, la presente Norma può essere usata anche per
cliniche e ambulatori veterinari” (nota del paragrafo 710.1.1).
Si ritiene, infatti, vivamente consigliabile utilizzare queste Norme anche
per gli animali, in particolar modo quando si è a conoscenza che la specie
che si sta trattando ha, per sua costituzione, una resistenza elettrica
molto bassa, inferiore anche ai 1.000 ohm convenzionali che si stimano per
gli esseri umani e non si deve considerare il rischio per l’animale solo
per il suo valore di mercato.
Individuazione del rischio Un secondo aspetto riguarda
l’individuazione del rischio per paziente che ricalca in alcuni casi
metodi già utilizzati, ma oggi con indirizzi più precisi.
Ad esempio, viene raccomandata una conoscenza specifica degli impianti
elettrici unitamente a quella degli apparecchi elettromedicali, specie
quando i pazienti vengono sottoposti a cure intensive di importanza
critica.
La valutazione del rischio per il paziente viene effettuata dal
responsabile clinico secondo i seguenti criteri:
 presenza di apparecchi elettromedicali (in caso di ambienti estetici:
apparecchi elettrici per uso estetico o apparecchi elettromeccanici) con
parti applicate;
presenza di apparecchi elettromedicali (in caso di ambienti estetici:
apparecchi elettrici per uso estetico o apparecchi elettromeccanici) con
parti applicate;
 se le parti applicate vengono utilizzate in modo invasivo interessando o
meno la zona cardiaca (introducendo i concetti di macro e microshock);
se le parti applicate vengono utilizzate in modo invasivo interessando o
meno la zona cardiaca (introducendo i concetti di macro e microshock);
 se la mancanza di alimentazione di trattamenti considerati “vitali” può
comportare pericolo per la vita del paziente.
se la mancanza di alimentazione di trattamenti considerati “vitali” può
comportare pericolo per la vita del paziente.
Classificazione dei locali ad uso medico
I locali ad uso medico vengono ufficialmente suddivisi in tre gruppi:
 gruppo 0: locale ad uso medico nel quale non si utilizzano
apparecchi elettromedicali con parti applicate;
gruppo 0: locale ad uso medico nel quale non si utilizzano
apparecchi elettromedicali con parti applicate;
 gruppo 1: locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzate nel modo seguente:
gruppo 1: locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzate nel modo seguente:
1) esternamente;
2) invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona
cardiaca;
 gruppo 2: locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi
intracardiaci, operazioni chirurgiche, oppure quando il paziente è
sottoposto a trattamenti vitali, dove la mancanza dell’alimentazione può
comportare pericolo di vita.
gruppo 2: locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi
intracardiaci, operazioni chirurgiche, oppure quando il paziente è
sottoposto a trattamenti vitali, dove la mancanza dell’alimentazione può
comportare pericolo di vita.
Per i locali di gruppo 2, le Norme aggiungono poi la seguente nota:
“Un intervento intercardico è un intervento in cui un conduttore elettrico
è posto entro la zona cardiaca di un paziente o è probabile che entri in
contatto con il cuore, mentre tale conduttore è accessibile all’esterno
del corpo del paziente. A questo riguardo si considerano conduttori
elettrici i fili isolati, quali gli elettrodi di un pacemaker (n.d.r.:
quando il pacemaker è alimentato provvisoriamente dall’esterno) o gli
elettrodi di un E.C.G .(n.d.r.: si tratta sempre di un E.C.G.
intracardiaco, non del normale E.C.G.che si esegue in un ambulatorio
cardiologico) od i cateteri riempiti di fluidi conduttori (n.d.r.: possono
essere fluidi conduttori anche il sangue e le soluzioni fisiologiche)
applicati in zona cardiaca”.
Come si nota, i locali ad uso medico sono classificati in base ai nuovi
approcci. E’ comunque indispensabile che le definizioni ed i rischi ad
essi connessi vengano sempre stabiliti dopo attente valutazioni con il
responsabile “clinico o medico”, che dovrà valutare l’entità del rischio,
il pericolo di macro e microshock
 (cfr.
box 1), il tipo di intervento da effettuare, gli
apparecchi elettromedicali da utilizzare, l’eventuale tipo di anestesia
praticata e se la mancanza di qualsiasi tipo di energia possa mettere in
pericolo la vita del paziente.
(cfr.
box 1), il tipo di intervento da effettuare, gli
apparecchi elettromedicali da utilizzare, l’eventuale tipo di anestesia
praticata e se la mancanza di qualsiasi tipo di energia possa mettere in
pericolo la vita del paziente.
Secondo la Norma, una sala operatoria o un ambulatorio chirurgico devono
essere sempre considerati come locali medici di gruppo 2 (cfr. tab. B.1
dell’Appendice della Parte 7 – Sez. 710 delle Norme CEI 64-8/7). E’ pur
vero, però, una sala operatoria per piccoli interventi, ad esempio sulle
parti terminali degli arti superiori o inferiori (mani e piedi) – a
maggior ragione se in anestesia locale o loco-regionale – non presenta
rischio di microshock. Se questo fosse confermato dal medico specialista
(medico legale), il locale potrebbe essere riconosciuto di gruppo 1. Di
conseguenza, solo la valutazione del rischio da parte del responsabile
sanitario in relazione al macro e microshock porta a stabilire il gruppo
di appartenenza del locale.
Non si deve essere trascinati dalle definizione di sala operatorio o
ambulatorio chirurgico. Si ricade sempre in un locale di gruppo 2. Non
sempre un locale di gruppo 2 è con pericolo di microshock.
Non sempre l’egidia del “melium est abundare quam deficere” è la
soluzione.
Per ipotesi. Se si effettuasse un intervento di appendicectomia in
anestesia locale di tipo “spinale (aspirazione lombare)” e in questo
locale non si eseguissero mai interventi con pericolo di microshock (è
impossibile, per ora, eseguire un intervento cruento nella regione
cardiaca in anestesia locale), l’ambiente potrebbe anche essere
classificato di gruppo 2 senza pericolo di microshock (meglio però
attenersi alla decisione del “clinico”).
Se nel locale non può verificarsi pericolo di microshock, in quanto non si
è in un reparto pediatrico o di chirurgia d’urgenza e non verranno mai
effettuati interventi in zona cardiaca o toracica, tale locale potrebbe
essere considerato di gruppo 2 senza pericolo di microshock o magari, in
casi particolari, anche di gruppo 1.
Un concetto importante, introdotto dalla Norma per i locali di gruppo 2,
riguarda il trattamento vitale, ossia la considerazione che la mancanza di
alimentazione può comportare pericolo per la vita del paziente.
Si ritiene che con il termine “alimentazione” ci si debba riferire alla
mancanza di qualsiasi energia e non solo a quella elettrica, come indicato
dalla Guida (cfr. punto 2.7, figura 2.1). si pensi, ad esempio, alla
distribuzione dei gas medicali (oggi identificati con medicinali) che
normalmente avviene utilizzando serbatoi in pressione. Tale pressione è
normalmente fornita da due pressostati forniti di due contatti (preallarme
e allarme).
In conseguenza di ciò, i locali di gruppo 2 risultano in pratica suddivisi
in due sottogruppi:
 sottogruppo 2 senza pericolo di microshock: locali dove il paziente è
sottoposto o solo a trattamenti vitali, dove la mancanza di alimentazione
di questi può comportare pericolo per la sua vita, o ad interventi
chirurgici senza pericolo di microshock;
sottogruppo 2 senza pericolo di microshock: locali dove il paziente è
sottoposto o solo a trattamenti vitali, dove la mancanza di alimentazione
di questi può comportare pericolo per la sua vita, o ad interventi
chirurgici senza pericolo di microshock;
 gruppo 2 con pericolo di microshock: locali dove le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzati in applicazioni quali interventi
intercardiaci, operazioni chirurgiche , ecc.. Gli interventi possono
essere associati o meno a quanto citato sopra.
gruppo 2 con pericolo di microshock: locali dove le parti applicate sono
destinate ad essere utilizzati in applicazioni quali interventi
intercardiaci, operazioni chirurgiche , ecc.. Gli interventi possono
essere associati o meno a quanto citato sopra.
In definitiva, per la determinazione del rischio, e quindi della
classificazione dei locali ad uso medico (gruppo 1 o gruppo 2), è
fondamentale non solo considerare il pericolo di microshock, ma anche
valutare, soprattutto in alcuni casi specifici, la possibilità o meno
dell’anestesia generale e l’eventualità che l’assenza di qualsiasi energia
determini pericolo di vita per il paziente.
Zona paziente
E’ stata istituita la “zona paziente” sia nei locali di gruppo 1, sia in
quelli di gruppo 2. Essa occupa un volume identificato da un solido
geometrico irregolare composto da un parallelepipedo a spigoli
arrotondati, appoggiati al piano di calpestio e con un’altezza che varia
secondo il piano di appoggio del paziente sdraiato in posizione supina sul
lettino (la massima quota occupata dallo stesso nel caso il paziente fosse
seduto), cui va sovrapposto un tronco di cono irregolare che ha come base
il lato superiore del parallelepipedo ed altezza 2.5 m
(figura 1, tratta dalle nuove Norme CEI).

L’introduzione della zona paziente non sembra, in effetti, aver modificato
molto la normativa pregressa. E’ importante mantenere l’equipotenzializzazione
al nodo o sottonodo e l’eventuale alimentazione attraverso trasformatore
d’isolamento quando un pensile o una scialitica possono scendere al di
sotto dei 2.5 m dal piano di calpestio. Valutando l’entità dei rischi:
quale tecnico assumerebbe la responsabilità, specie in un locale ad uso
medico con pericolo di microshock, di fornire energia ad una qualsiasi
presa, anche se fuori dalla “zona paziente”, non derivata da trasformatore
d’isolamento? (fatta eccezione sempre per le prese che devono alimentare
apparecchi radiologici o carichi con potenza nominale superiore a 5 kVA).
Si osserva, inoltre, come l’utilizzo di spazi angusti porti la zona del
paziente ad essere identificata con le pareti, il soffitto ed il pavimento
del locale stesso, facendolo considerare identico a quello della ormai
superata Norma 64-4.
| Le prescrizioni normative
introdotte con la Variante V2 alla Norma CEI 64-8, incluse poi con la
quinta edizione della suddetta Norma nella Parte VII, commentate
tenendo conto anche della recente Guida CEI 64-56. |
 |
 Anestesia
Anestesia
Per quanto riguarda l’anestesia generale, questa viene ricordata solo
sulla Guida. Per alcuni è un aspetto che non ha grande influenza; per
altri, quando esiste rischio macro e/o microshock, le percentuali di
un arresto cardiaco o respiratorio durante un intervento vengono
modificate se l’intervento è effettuato in anestesia generale o locale
o locoregionale. Sembrerebbe che in anestesia locale questa
percentuale scenda verso lo zero. Ecco che anche un semplice
intervento di appendicectomia o sugli arti cambia notevolmente la
percentuale di rischio, che si abbassa quando si usa l’anestesia
locale o locoregionale e si alza quando si usa l’anestesia generale
(cfr. box 2).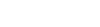
Sistema IT – M
Viene definito IT – M (medicale) il sistema di distribuzione
utilizzato nei locali di gruppo 2 con pericolo di microshock, per
distinguerlo da un usuale sistema IT. Il sistema IT – M è un ibrido in
quanto consente una separazione elettrica tra primario e secondario,
ma, contrariamente ad un sistema IT ordinario, rende obbligatoria la
messa a terra (m.a.t.) delle masse. Conseguentemente i trasformatori
d’isolamento, destinati ad alimentare detto sistema, vengono definiti
“Trasformatori d’isolamento medicali” e devono essere conformi alla
Norma IEC 61558-2-15 (se applicabile).
Per i locali di gruppo 2 con pericolo di microshock non vi è l’obbligo
di alimentare tutti i carichi elettrici che superano i 5kVA attraverso
trasformatore d’isolamento medicale; tale obbligo permane solo per
quelli che non superano i 5 kVA e possono interessare la zona del
paziente (tuttavia, per evitare che qualsiasi carico alimentato da
gruppi presa/spina venga portato nella zona paziente è necessario
alimentare tutte le prese o i gruppi di prese bipolari anche 10/16 A
tramite sistema IT – M). Sebbene la nuova normativa dimentichi questo
argomento, anche i telefoni collegati via cavo sono sempre pericolosi,
soprattutto là dove esiste pericolo do microshock. O si installano in
un punto dove non interferiscono direttamente o indirettamente con la
zona del paziente, o la linea telefonica che accede alla zona paziente
deve essere interrotta da un trasduttore (ad esempio, convertitore di
segnale elettrico/ottico).
Il trasformatore d’isolamento di tipo medicale, usato nei locali di
gruppo 2 con pericolo di microshock, ha taglie maggiori rispetto alle
precedenti norme (da una potenza massima di 7.5 kVA si passa a 10 kVA),
deve sempre avere una tensione nominale al secondario non superiore a
250 V, 50Hz, e deve essere sempre identificato da un logo particolare
 (figura 2).
(figura 2).
Il trasformatore può essere trifase. In questo caso deve alimentare
esclusivamente un carico trifase (è vietato alimentare un carichi
monofase, anche equilibrandoli).
Costruttivamente può essere con avvolgimenti su una o su due o più
colonne; è sufficiente rispettare tutti i parametri richiesti dalla
Norma di prodotto. Le Norme raccomandano, inoltre, che sia dotato di
sonde di controllo della temperatura inserite nell’avvolgimento
secondario, per controllare con più efficacia anche il sovraccarico
del trasformatore.logicamente il sovraccarico dovrà avvertire il
personale medico e paramedico, attraverso segnali acustico/luminosi,
in modo tale che questo possa intervenire a staccare alcuni carichi
che non fossero più necessari.
Salvo rarissime eccezioni, il trasformatore d’isolamento medicale va
sempre corredato da un sistema di controllo d’isolamento, con
dispositivi di allarme acustici e luminosi installati sia dove è
collocato il trasformatore di isolamento medicale, sia a distanza
(normalmente nel locale ad uso medico interessato).
Conduttori
Nei locali di gruppo 2 con pericolo di microshock non è più richiesto
l’uso di cavi multipolari (principalmente bipolari) a “trefolo” anche
a valle dei trasformatori d’isolamento, in quanto si è constatato che,
anche i fenomeni di capacità verso terra non rivestono significativa
importanza in relazione ai disturbi che si possono manifestare.
Poiché i circuiti derivati da un sistema IT – M devono essere
necessariamente separati da circuiti elettrici alimentati da altri
sistemi e , quindi, essere contenuti in tubazioni o cabalette o
cassette indipendenti (per la cabalette e le cassette è sufficiente un
setto di separazione), in queste condizioni anche i circuiti del
sistema IT – M possono essere realizzati usando cavi unipolari (cordine)
tipo NO7V – K (attenzione al colore dei conduttori: nessun conduttore
dovrà essere blu o azzurro o celeste, in quanto un sistema IT – M non
ha mai neutro). Se risultasse impossibile la realizzazione di una
separazione fisica di due sistemi elettrici ed il circuito IT – M
dovesse percorrere una canalizzazione in “comune” con un altro
sistema, si devono utilizzare cavia doppio isolamento (bipolari o
tripolari, secondi se il circuito è monofase o trifase) di tipo FG7OR
06/1 kv con guaina non metallica (1).
Particolare attenzione deve essere posta quando si è in presenza di
locali particolari. Ad esempio, per locali di gruppo 2 come terapia
intensiva, rianimazione e similari, dove gli apparecchi
elettromedicali per il controllo e l’assistenza dei parametri vitali
hanno utilizzo maggiore nel tempo, è bene che i conduttori siano
schermati o che vengano inseriti in tubazioni metalliche
equipotenzializzate. Per locali di radiologia, TAC e locali con
apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti, è bene che i
conduttori di alimentazione non interrompano le schermature
antiradiazione predisposte.
Unità di alimentazione
Con la pubblicazione della Norma UNI EN 793 sono state fissate le
caratteristiche delle unità di alimentazione per uso medico, ossia
apparecchi anche di notevoli dimensioni, prefabbricati o in unico
blocco o modulari, ad installazione permanente e destinati a fornire
qualsiasi tipo di energia o servizio per la salvaguardia e/o il
miglioramento della qualità di vita per il paziente o il degente. Le
unità di alimentazione comprendono, quindi, oltre ai servizi elettrici
e/o di illuminazione, anche i servizi di telecomunicazione,
trasmissione dati, distribuzione ossigeno terapeutico, gas medicali,
vuoto, aria compressa sterile, ecc. (2).
Le unità di alimentazione sono di diversi tipi e vengono utilizzate
sia in locali di gruppo 1, sia in locali di gruppo 2. ricordiamo i
testaletto per la camere di degenza, i testaletto per risveglio,
terapia intensiva e/o rianimazione, gli stativi o pensili per sale
operatorie, ecc..
Le unità di alimentazione non devono avere organi di protezione
elettrici (interruttori o fusibili) accessibili direttamente
dall’esterno, per evitare errate manovre. Le singole prese possono
essere protette con fusibili o interruttori automatici, purché
posizionati o segregati in un vano dell’unità di alimentazione
accessibile solo con l’uso di un attrezzo (chiave,cacciavite,ecc.),
come indicato dalla
figura 3.

Alimentazione e protezione delle prese a spina nei locali di gruppo
2
Per i locali di gruppo 2, le Norme prescrivono che (paragrafo
710.55.3.3): “in ciascun posto di trattamento dei pazienti, per
esempio le unità di alimentazione ad uso medico (testaletto), la
disposizione delle prese a spina alimentate del sistema IT – M e dei
relativi circuiti deve essere la seguente:
 devono essere installati almeno due distinti circuiti che alimentano
le prese a spina, oppure;
devono essere installati almeno due distinti circuiti che alimentano
le prese a spina, oppure;
 le prese a spina devono essere protette individualmente o a gruppi
(almeno a due) contro le sovracorrenti”.
le prese a spina devono essere protette individualmente o a gruppi
(almeno a due) contro le sovracorrenti”.
Alla luce di queste disposizioni è consigliabile adottare sistemi
diversi secondo il rischio presente nel locale e si alimentano
pannelli prese o singole prese o prese inserite in unità di
alimentazione ad uso medico, come precisato nella
 tabella 1.
tabella 1.
Collegamenti equipotenziali
E’ stato abolito l’uso dell’anello equipotenziale: l’equipotenzializzazione
deve essere sempre effettuata con l’ausilio di nodo e sottonodi (o
subnodi) nei locali di gruppo 1 e 2.
Si rammenta che ogni ramo derivato dal nodo può portare solo ed
esclusivamente un unico sottonodo.
Ai nodi e ai sottonodi vanno collegate indistintamente le masse e le
masse estranee. Si devono quindi equipotenzializzare con conduttori
giallo/verde le seguenti parti, se entrano nella “zona paziente”,
secondo le modalità indicate:
 masse e alveolo di terra delle prese (conduttore di protezione PE con
sezione minima uguale a quella del conduttore di fase);
masse e alveolo di terra delle prese (conduttore di protezione PE con
sezione minima uguale a quella del conduttore di fase);
 masse estranee (conduttori equipotenziali EQS con sezione minima di 6
mm2 se in rame);
masse estranee (conduttori equipotenziali EQS con sezione minima di 6
mm2 se in rame);
 schermi contro le interferenze elettriche, se installati;
schermi contro le interferenze elettriche, se installati;
 eventuali griglie conduttrici nel pavimento e nelle pareti;
eventuali griglie conduttrici nel pavimento e nelle pareti;
 eventuale schermo metallico del trasformatore d'isolamento;
eventuale schermo metallico del trasformatore d'isolamento;
 tavoli operatori a posa fissa, anche non elettronici, ne non sono
destinati ad essere isolati da terra.
tavoli operatori a posa fissa, anche non elettronici, ne non sono
destinati ad essere isolati da terra.
Si ricorda che, escludendo i locali di gruppo 0, che nono necessitano
di equipotenzializzazione, la presenza di una massa estranea si
verifica stabilendo se nel locale esiste rischio di macro e/o
microshock. Nella quasi totalità dei locali di gruppo 2, dove è
presente il rischio di microshock, la parte metallica, per essere
considerata massa estranea, deve presentare una resistenza verso terra
minore di 0.5 MOhm .
Nei locali con presenza di rischio di solo macroshock, il limte di
resistenza verso terra da considerare è 200 Ohm.
Per le prese od altri collegamenti che fanno parte di un tastaletto o
di un pensile o di qualsiasi altra unità di alimentazione contemplata
dalle Norme UNI EN 793, il collegamento comune dei relativi conduttori
PE è da considerarsi a tutti gli effetti all’interno dell’apparecchio
e, quindi, non deve essere ritenuto un sottonodo dell’impianto
elettrico.
Il valore massimo di resistenza ammesso per un collegamento
equipotenziale supplementare in un locale di gruppo 2 passa da 0.15
Ohm a 0.20 Ohm.
Pavimenti antistatici
Non vengono più citati i pavimento antistatici.
Questo è dovuto al sempre più largo uso dell’anestesia per infusione.
Tuttavia, se sono presenti pericoli di esplosione(in quanto sono
utilizzati ancora gas medicali per via inalatoria in quantità
superiori a quantità superiori a quelle citate dalla vecchia Norma CEI
64-4), l’adozione di pavimenti antistatici non è solo opportuna, ma
richiesta.
Di Carlo Cattaneo
Articolo apparso sulla rivista Elettrificazione numero 4,
aprile 2004.
NOTE
(1) Il Trasformatore d’isolamento ha una separazione di protezione tra
gli avvolgimenti, costituita da un isolamento doppio o rinforzato o da
uno schermo collegato a terra. Per questa ragione tutti i circuiti del
sistema IT – M (a valle del trasformatore d’isolamento) devono essere
separati da quelli di altri circuiti (tra circuiti tutti alimentati da
sistema IT – M posati nello stesso canale o casetta non è necessario
il setto di separazione). Qualora i conduttori di due sistemi
elettrici diversi ( ad esempio, IT – M + ordinario) dovessero
coesistere nella stessa canalizzazione, i conduttori del sistema IT –
M dovranno essere a doppio isolamento ed avere tensione nominale
maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema
elettrico servito.
(2) Se il testaletto contiene solo apparecchi di illuminazione non è
da considerarsi un’unità di alimentazione per uso medico.
|
|


 E’ stata recentemente edita dal CEI una Guida riguardante i locali ad uso
medico, per i quali sono entrate in vigore le nuove prescrizioni
introdotte dalla Variante V2 alla Norma CEI 64-8, che ha abrogato la Norma
CEI 64-4.
E’ stata recentemente edita dal CEI una Guida riguardante i locali ad uso
medico, per i quali sono entrate in vigore le nuove prescrizioni
introdotte dalla Variante V2 alla Norma CEI 64-8, che ha abrogato la Norma
CEI 64-4.